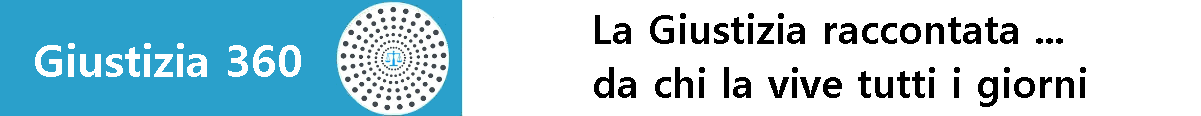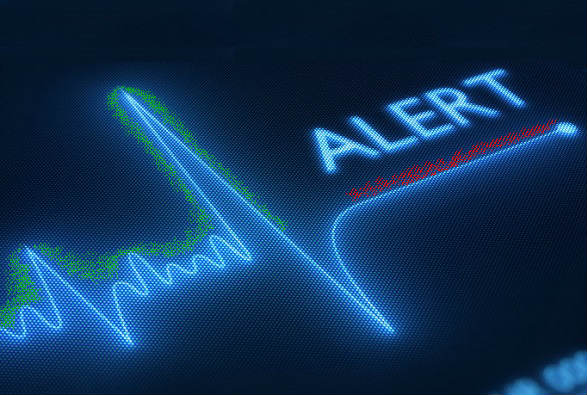Morte Senza Sofferenza per Editto della Giurisprudenza
Le sezioni unite della cassazione hanno stabilito che, in caso di morte istantanea di un soggetto, non è liquidabile il danno biologico in quanto “nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo pochissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva dall’assenza di un soggetto al quale, quando si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio sia acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (nella specie, un uomo, a causa di un impatto avvenuto a 103 kmh, era ritenuto deceduto istantaneamente).
Alla luce delle considerazioni che seguiranno, pare a noi che valga la pena di attivare una riflessione dialettica sugli argomenti – sicuramente meditati – con cui la giurisprudenza ha stabilito l’irrilevanza (datane la brevità) di quel “pochissimo tempo dalle lesioni personali”, ai fini del potersi concretizzare un danno risarcibile, chiedendosi se possa accadere sia che essi urtino sia che con regole di esperienza, individuale e collettiva e sia che la loro assolutezza non sia del tutto legittimata dalle conoscenze scientifiche.
Ciò in primo luogo in quanto, naturalisticamente, la previsione della perdita del bene vita vissuta da un soggetto, benché brevissima, è già da sola e in qualsiasi circostanza, un danno. E può considerarsi, anzi, “il danno” per eccellenza la cui attiva sofferenza – psichica o anche contestualmente fisica – può essere provata, ed è sentita incrementata, proprio e soltanto in chi ha la consapevolezza di trovarsi al limitar di Dite in un momento che può parer breve o addirittura brevissimo a un osservatore terzo , ma è sicuramente lunghissimo per lui che lo sta vivendo.
Si pensi a un soggetto che, spinto, cada dalla cima di un grattacielo… Può davvero ritenersi che, “strada facendo” costui non subisca personalmente danno soltanto perché l’intervallo tra il momento in cui la sua morte gli si profila imminente e il momento della stessa sarà solo questione di secondi? O non può, invece, essere vero che quel soggetto – come pure quello che decederà dopo pochissimo tempo dalle lesioni personali – avrà sofferto, durante il breve ma eterno tragitto, il massimo del dolore, sicuramente superiore a quello di un altro individuo cui sia stata fracassata una gamba o amputata erroneamente una mano; e lo avrà sofferto proprio perché “pre-sente” che quello che si accinge a perdere irreversibilmente è proprio tutto intero il bene vita?
Quale differenza sussisterebbe, quoad tempus relazionato alla categoria “acquisto”, tra costui e un soggetto fortunato che in un casinò, grazie a una vincita, può consumare la “propria capacità di acquistare” nei pochi secondi dei giri di una roulette. Acquisto che non verrebbe meno se coincidesse con la sua istantanea morte per infarto causata dall’emozione vissuta tra il momento della caduta della pallina e il suo arresto.
Però, adattando all’esempio succitato il giudizio della corte, quei medesimi secondi non basterebbero a chi precipiti perché si “verifichi una perdita rapportabile a un soggetto”; sicché la perdita vissuta lungo la caduta non sarebbe acquistabile da costui, ma costituirebbe solo lo spunto – letto evidentemente in senso negativo – per il “conseguimento di più denaro ai congiunti”.
Per collocare le riflessioni che seguono legandole a quando precede, ci soffermi a riflettere proprio su quanti si gettarono nel vuoto dalle Torri Gemelle di New York dopo l’attacco terroristico operando una scelta produttiva di una duplice: quella sicuramente provata nella fase opzione per una decisione dagli esiti solo fatali e quella provata durante il volo destinato ineluttabilmente a concludersi letalmente sul suolo.
Tutti quegli esseri, consapevoli dell’imminente morte, hanno sicuramente subìto tempeste ormonali fisiologiche – rilevabili se fossero state disposte specifiche indagini post mortem – che li hanno fatti soffrire sottoponendoli a violente stimolazioni dettate dal rilascio di adrenalina con contemporanee secrezioni di antagonisti con potere calmante (come la serotonina e l’acido gammabutirrico) le cui attività rallentano la trasmissione nel sistema nervoso centrale dell’adrenalina i cui danni, se rilasciata in condizioni estreme, possono anche comportare la morte.
Potrebbe argomentarsi diversamente nel caso in cui la morte sopravvenisse per causa di terzi, ma senza avere il tempo di realizzare l’imminente trapasso pur avendo consapevolezza del fatto che il pericolo che si sta profilando può avere un carattere estremo?
Potrebbe essere. E forse no.
Per propendere in quest’ultima direzione potrebbe essere indicativo – attingendo ad eventi documentati – “leggere” al rallentatore quanto dice con estrema chiarezza il filmato della caduta rovinosa del ponte avvenuta qualche tempo fa sulla superstrada tra Lecco e Milano: la visibile frenata attuata all’ultimo momento dallo sventurato che in quel momento era già sotto il ponte è prova che egli – in un lasso di tempo infinitesimale – ha realizzato ciò che stava accadendo proprio a lui reagendo tempestivamente al pericolo imminente con lo spirito della life-force adrenalinica, ma tuttavia reagendo insufficientemente dal punto di vista del tempo fisico per cui il ponte gli rovinò addosso uccidendolo.
Se la giurisprudenza vedesse giusto, dovrebbe escludersi che dal momento in cui egli percepì il pericolo abbia avuto il modo e il tempo sufficiente per soffrire intensamente e sicuramente più di colui cui stesse per cadere un mattone su un piede fratturandoglielo?
E cosa ne sarebbe di quel dolore se la morte fosse istantanea nel senso inteso dalla corte di cassazione (“dopo pochissimo tempo”) e la sofferenza dovesse davvero misurarsi in termini di durata e non di qualità?
E’ ragionevole una diversa lettura del fenomeno?
Proviamo a speculare oltre al riguardo.
Una seconda riflessione perplessa ci è indotta dal concetto giurisprudenziale di morte istantanea; ossia del momento irreversibile del passaggio “immediato” dall’essere al non essere; dall’essere “soggetto” all’essere un’entità priva di soggettività. Concetto che, per essere attendibile, presupporrebbe risposte a una successione di domande.
Quando può dirsi del tutto compiuto quel passaggio e, lungo o breve che sia, cosa accade nel suo prodursi?
Può affermarsi con sufficiente certezza quando, lungo quel tragitto, cessino le out-of-body experiences di cui si ha notizia da quanti rientrano dallo stato comatoso?
Può affermarsi con altrettanta certezza che esse cessino in coincidenza con la perdita di coscienza?
E’ privo di dubbi lo stabilire la coincidenza tra la perdita di coscienza e mancanza di sofferenza?
Quella mancanza di sofferenza potrebbe essere dovuta ad altro – ad esempio a una reazione difensiva sviluppata dall’organismo – rispetto alla perdita di coscienza?
Qualsiasi organismo svilupperebbe le identiche difese o, essendo esse di intensità diversa, si avrebbe una ricaduta sulla “soffribilità”?
Procedendo per passi nell’avanzare il nostro dubbio quanto al fatto che le domande abbiano avuto ad oggi una definitiva risposta, ricordiamo che sono state fatte ricerche su cadaveri dai quali è stata isolata la ghiandola pineale ricercando nella stessa la molecola “dimetiltriptamina” detta DMT di cui poi si dirà. I tessuti che la componevano erano “morti” ma nella ghiandola esistevano tutti i “mattoni” per continuare a produrre la DMT anche per un certo tempo dopo il sopravvenire della morte fisiologica.
Il che legittima il ribadire la domanda se si sia già certi di poter dare una risposta definitiva agli interrogativi posti e se sia ragionevole aspettarsi nel futuro una risposta diversa da quella che potrebbe essere data – e la corte ha dato – oggi. (Forse non sarebbe male, prima di escluderlo, ricordare la frase di un romanziere – Dan Brown in – “se i nostri antenati dovessero rinascere e vedere ciò che abbiamo fatto ci scambierebbero per delle “divinità”.
Dubbio legittimo visto che se ora si favorisce il concetto di morte cerebrale – che coincide con l’irrimediabile perdita di funzionalità del cervello (la quale tuttavia non esclude la sopravvivenza di altri organi che, in effetti, di funzionalità possono averne ancora. Tant’è che possono essere trapiantati) – in precedenza vigeva, dandolo altrettanto per certo, il concetto di morte cardiopolmonare. E anche visto che ci sono studiosi che sostengono che la cessazione dell’attività cerebrale da sola non basta e con essa deve coincidere anche la cessazione dell’attività polmonare e di quella cardiaca…. Il che ha indotto qualcuno a osservare che se una volta l’attività coordinatrice delle funzioni era stabilita nel cuore, un’altra volta nei polmoni, poi in entrambi, ora nel cervello, domani in cervello-cuore-polmoni, non può escludersi che quella attività non vada invece stabilita – o che non sarà un giorno anche stabilita – nel fegato, visto che se la sua funzionalità viene meno l’organismo ha brevi possibilità di vita.
Dunque si direbbe che solo “in questo momento” perché si verifichi la “cessazione dell’essere come organismo funzionalmente integrato” – ossia la morte – basterebbe la interruzione della sola attività del cervello (che non coincide con la perdita della capacità dell’individuo di autodeterminarsi visto che la perdita di spontaneità del funzionamento di quell’organo e dell’organismo non è ancora morte dell’essere che è considerato “esistente” – anche se in forza di un accanimento terapeutico – finché venga tenuto in vita artificialmente da un apparecchio che sia il solo ad assicurare al corpo di esistere come organismo funzionalmente integrato).
Alla luce di quanto accennato parrebbe quanto meno ragionevole la conclusione che, in termini medico-legali, la morte non coincida con indispensabile certezza con quello che – ragionando in termini naturalistici – è il “punto finale del processo evolutivo che colpisce gradualmente tutte le cellule dei diversi tessuti e le relative strutture subcellulari fino all’estinzione di ogni attività vitale con il permanere dei soli fenomeni enzimatici colliquativi-putrefattivi” (traggo la citazione, il cui autore mi è ignoto, da “Morte e persona” di Bruno Morcavallo)
E, allora, morte è uno “stato” convenzionalmente stabilito?
… Convenzionalmente, peraltro, neppure con certezza visto il dissenso tra studiosi cui si è accennato.
E’, però, proprio vero che il fenomeno morte – come momento della cessazione della vita – va individuato nella lettura che se ne fa oggi in campo medico, ossia nell’irreversibilità della perdita di funzionalità dell’organismo, e non potrebbe essere letto piuttosto nella cessazione irreversibile di qualsiasi sentire e dunque essere da parte di qualsiasi componente del corpo umano quanto alla natura, intensità, durata delle quali sembra non si sappia ancora a sufficienza e molto però sembrerebbe si possa intuire dagli studi sul genoma?
Basti pensare… Oggi trapiantiamo il cuore (un tempo ritenuto la sede dell’anima) e non sappiamo assolutamente nulla quanto a “se” e “cosa” esso trasferisca della “umanità” del donatore nell’essere del trapiantato… Ma semmai in un domani che sembrerebbe prossimo venisse realizzato il trapianto di una testa tutta intera – il neurochirurgo torinese Sergio Canavero sostiene essere già cosa fattibile (operazione che il chirurgo americano Robert White effettuò nel 1970 su una scimmia che sopravvisse alcuni giorni all’intervento) – non è ragionevole ipotizzare (e comunque: non sarebbe arbitrario escludere) che esso porterebbe seco la consapevolezza di sé del donatore?
Concludendo, e a tale scopo ritornando all’esempio dell’uomo finito sotto il ponte crollato, per statuire quando si verifichi l’assenza istantanea non sarebbe indispensabile dare prima risposte attendibilmente definitive alle domande: “Quand’è che l’ultima delle cellule del suo corpo ha finito di soffrire per il risentimento fisico dell’urto? Quand’è che l’ultima di esse ha cessato di risentire la perdita del ? E’ certo che quel risentimento non ha coinvolto tutto l’essere?”?
Può essere che – per stabilire se sia da cercare, sull’evento “morte”, una risposta adattabile al diritto che vada oltre la medicina – potrebbero fornire ispirazioni gli studi sulle “sensazioni” degli esseri monocellulari, sulla loro possibilità di archiviazione di esperienze e della loro trasmissione nella mitosi o per meiosi, pur non essendo dotati di un sistema nervoso (pensiamo di quanto sia portatore l’ovulo fecondato che è uno di quegli esseri monocellulari)?
… Chi si sentirebbe di escluderlo, vista la velocità alla quale procede la conoscenza scientifica progredendo in maniera che pare inarrestabile.
E’ anche per questo che la parola fine pronunciata dalle Sezioni Unite potrebbe rivelarsi tutt’altro che appropriata.
Può essere che per stabilire dove cercare quella risposta adattabile al diritto che vada oltre la medicina ci si possa orientare attraverso la biologia molecolare e la chimica?
Torniamo alla dimetiltriptamina, alla DMT di cui si è detto dianzi.
Che cos’è?
Una molecola semplice – endogena, ma anche di sintesi – potentissima.
Essa viene prodotta dal nostro cervello mentre dormiamo e il suo picco massimo è registrabile
nella fase del sonno profondo (o REM) durante il quale, generalmente, si sogna.
Tale molecola ha una funzione complessa che non è stata ancora completamente svelata, ma numerosi scienziati, che l’hanno inoculata su volontari sani nel più esauriente studio sin qui eseguito con sostanze serotonino-simili, hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi della “molecola dello spirito umano” delegata a svolgere il ruolo di
intervenire in tutti quegli stati estremi in cui l’essere non saprebbe orientarsi o reagire.
Ansietà, depressione e stress ne sarebbero i target privilegiati.
Quel che rileva, in relazione a questo scritto, è che uno degli appuntamenti che l’uomo avrebbe con i benefici della DMT potrebbe essere quello che si profila alla soglia dell’ultimo viaggio – quello della morte e della sperata rinascita nell’altro mondo – protraendosi rispetto al momento che per le nostre conoscenze attuali segna “la morte”.
Infatti la nostra ghiandola pineale , sede della produzione della DMT, continua a produrne per oltre quarantotto ore dopo la morte!
Con quale effetto e, ragionevolmente, con quale scopo se con la morte il “soggetto è finito”?
La DMT è uno psichedelico endogeno naturale (presente nel regno vegetale ed animale, compreso l’uomo, nel fluido cerebrospinale) che si ritiene svolga un ruolo pacificante decisivo negli stati di coscienza straordinari – con effetti simili a quelli “raccontati” da soggetti restituiti alla coscienza dallo stato di coma (grande luminosità e senso di distensione) – per cui si potrebbe ipotizzare che la sua produzione possa avere l’effetto, se non addirittura essere finalizzata – ad agevolare la serenità del passaggio. Sarebbe stato di interesse accertare se – nel caso dei caduti dalle Torri Gemelle, con possibile morte in volo per infarto del miocardio originato dall’emozione violenta e traumatica – sia stata liberata proprio la molecola DMT così, forse, alleviando il passaggio dalla vita a uno sconosciuto altro stato, interdicendo la tragica consapevolezza della transizione e ingenerando un benefico torpore rilassante.
Se così fosse, potrebbe quindi trattarsi di un viatico naturale che parrebbe avere un senso – e in natura non c’è nulla che non lo abbia finalisticamente – solo se con la morte verificatasi immediatamente o dopo pochissimo tempo dalle lesioni personali non coincidal’assenza del soggetto e perduri invece un essere al quale, quando si verifica, sia collegabile la perdita stessa (e dunque, ma questo è un aspetto che non interessa questo scritto, nel cui patrimonio sia acquisito il relativo credito).
Certamente ci siamo avventurati su un terreno minato senza essere medici o biologi – e pertanto può esserci giustamente ricordato di aver disatteso la antica raccomandazione silete clerici in munere alieno (….Ma andrebbe ricordato soltanto a noi?) – tuttavia questo nostro azzardo non sarà del tutto inutile se attiverasse un confronto e comunque esso di concludesse.
Domenico Carponi Schittar, Avvocato in Venezia
Marcello Fumagalli, chimico in Como