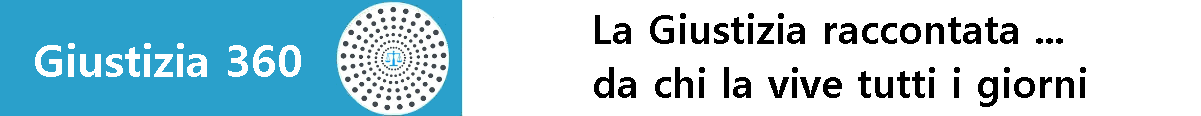La Legge Deve Essere Chiara. A chi lo dici!
Uno dei detti epigrafici attribuiti a Francesco Bacone è che “per la legge è di grande importanza essere chiara poiché questo è il presupposto perché non sia ingiusta”, cui potrebbe fare eco il detto di lord Halifax che “se le leggi potessero parlare per prima cosa si lamenterebbero dei giuristi”.
Al primo detto fu rigorosamente allineato il nostro codice civile del 1942, coniato dal non ripetibile (e comunque sicuramente non ripetuto) concorso di soggetti che erano al tempo stesso giuristi, sociologi, filosofi dotati per di più dell’irrinunciabile requisito – che oggi sembra desueto – di conoscere perfettamente la lingua italiana.
Un codice talora icastico – come i comandamenti – chiaro e comprensibile quanto meno dai più finché sullo stesso non è caduta, e continua a cadere, la scure delle sottigliezze soprattutto della giurisprudenza.
Il che mi riporta alla memoria la barzelletta su Mosè che scende dal monte con le tavole ed enuncia la legge alla folla in trepida attesa suscitando consensi finché di tratta dell’onorare il padre e la madre e del ricordarsi di santificare le feste, ma quando passa al “non rubare”, “non desiderare la cosa d’altri”, “non desiderare la donna d’altri” raccoglie reazioni sempre più vivaci. Perché? “Ma come si fa – è la domanda – a non rubare, … siamo mercanti. Come si fa a non desiderare se quello che è nell’oasi ha le pecore grasse e io nel deserto le ho avvizzite e se si vede una bella donna ogni morte di rabbi?”. Cui Mosè replica: “Tranquilli. Questa è la legge. Poi viene la giurisprudenza”.
Proprio così: la giurisprudenza. Quella che, al suono di continui distinguo alimentati uno dall’altro come per una reazione a catena, riesce a evincere da norme lineari quello che probabilmente – non dico ragionevolmente – non solo l’uomo della strada ma neppure il benpensante, sulla scorta di una logica accessibile, si sarebbe aspettato contenessero. Ossia quel “tutto e contrario di tutto” che caratterizza troppo sovente plurime letture tra loro conflittuali di una stessa norma, non sempre placate dalle superinterpretazioni delle sezioni unite e invece controproducenti per la ordinata vita di un’ordinata società.
La linea di frattura sta nel fatto che oggi si direbbe che una cosa sia la logica comune e condivisa di coloro che formano “il contesto sociale” – quella dei “boni patresfamilias” dantan (i soggetti ragionevoli cui si accreditavano senso di responsabilità, prudenza e buon senso) – e sia invece altra cosa la logica giurisprudenziale che costituisce il prodotto di un “top”: quello degli specialisti del settore che sovente paiono aver perso i contatti col contesto sociale e con le sue esigenze di chiarezza e di ordine.
Sono due logiche che presentano una divaricazione crescente e sempre più dannosa socialmente. Infatti il progresso inevitabile della “divisione del lavoro in campo culturale attiva in ogni campo un processo inarrestabile alle fine del quale (…) lo specialista – come dice così bene una battuta celebre – saprà sempre di più su sempre di meno e alla fine saprà tutto su niente”. Ragion per cui “esiste il serio pericolo che costui perda sempre di più l’orientamento (…) fino a smarrire ogni capacità di giudizio sull’importanza e sul ruolo che spettano al suo settore specifico nell’ambito del più ampio sistema di correlazioni culturali all’interno del complesso sovraindividuale del sapere”.
(Scrivendo così nel 1973 in “L’altra faccia dello specchio”, Konrad Lorenz sembra aver dato ragione al pessimismo di chi nel XIV secolo aveva scritto – Richard de Bury in “Philobiblon” – che “chi professa la giurisprudenza non interpreta il diritto secondo l’intenzione del legislatore ma ne violenta il senso”).
Si direbbe, tuttavia, che la giurisprudenza sia solo emblematica del fatto che quel perdere e far perdere l’orientamento ce l’abbiamo nel sangue. Basti pensare – non è che un esempio tra migliaia possibili – al principio fondamentale dell’ontologia cristiana (ex nihilo fit ens creatum) che non è nel Libro ma scaturisce solo nel primo secolo dopo Cristo dalla mente di Filone d’Alessandria (De Somniis I,13) forse ispirato da un testo del II secolo a.C. (secondo libro dei Maccabei; VII,28) che gli ebrei ritengono apocrifo: “ figlio mio, contempla il cielo e la terra e tutte le cose e ricorda che Dio le ha tratte da…” . Da dove le avrebbe tratte? (1) Il testo originario dice “non le ha tratte dall’essere”. (2) Una versione più tarda dice “le ha tratte dal non essere”. (3) Infine la traduzione latina fissò la creazione “dal nulla. Un nulla che per definizione sembrerebbe non lasciasse spazi a interpretazioni e invece non fu esente da ulteriori distinguo visto che Plotino riuscì ad individuarne ben tre sottospecie: “un quasi nulla tratto dal nulla”, ma anche “un nulla esistente” e, infine, “un essere inesistente”. Esso divenne con Agostino ortodossia cristiana senza peraltro far venire meno acerrimi dissensi, sempre dottissimi, tra agostiniani, platonici e tomisti; … un po’ come accade per le sottigliezze di pensiero che dividono le sezioni della suprema corte.
Esagero nel dire che è un “in noi”?
Ecco un campione quanto mai attuale.
Il migrante non è l’immigrante. Tra i migranti ci sono i migranti perseguitati e i migranti per elezione (istruttiva la perorazione della Boldrini al riguardo perché si divenga, al più presto, come loro). C’è inoltre il migrante regolare che potrebbe essere un rifugiato – o anche un profugo – se il termine non sia usato nell’accezione giuridica – e potrebbe essere un richiedente asilo (con sottodistinzione tra chi lo ha già chiesto e chi deve ancora presentare la domanda). Nell’accezione giuridica invece c’è il migrante rifugiato con status e anche il rifugiato senza status per averlo perso. E c’è il migrante irregolare, o clandestino nel senso del codice penale (che è una definizione consentita, a differenza del termine clandestino non <penalistico> che ha contenuto discriminatorio e, se usato, è perseguibile). Infine – credo, solo per ora – c’è anche chi non è rifugiato, e però è “beneficiario di protezione umanitaria”. In altri tempi – con connotazione sempre negativa (basti riflettere su cosa pensavano i veneziani dei terrafermicoli mestrini) – la categoria era unica eppure si capiva comunque di chi si trattasse: erano tutti “quei che vien da fora”.
Comunque, finché i distinguo li fanno i nostri saputi politici e politicanti, può andarmi di traverso ma tuttavia andarmi bene. (Non siamo i soli a sottilizzare. Restando in tema, per gli inglesi un bianco che va a vivere all’estero è un expat, senza alcuna connotazione; se ci va un nero è un immigrato, con connotazione negativa). Quanto, invece, alla giurisprudenza, cinque decenni di esperienza sul campo mi legittimano a chiedermi se molti giurisperiti – pur scevri evidentemente da fini di violenza intesa nell’accezione di Lorenz – abbiano chiara la consapevolezza del loro ruolo e delle esigenze che la giurisprudenza dovrebbe soddisfare essendo destinata a incidere pesantemente su quel “più ampio sistema delle correlazioni sociali” che, per poter funzionare armonicamente, necessiterebbe più di certezze generalmente condivisibili che di sottili distinguo accessibili a pochi e da pochi fruibili.
Avv. Domenico Carponi Schittar