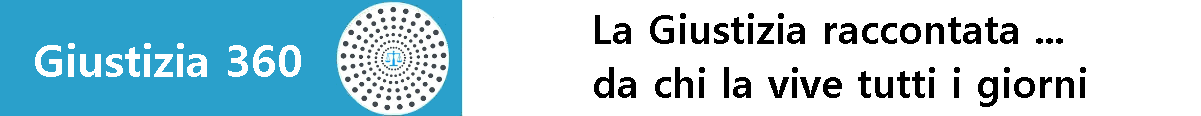Lo Avvocato nel Processo ed il Rito della Verità
Lo “Avvocato nel Processo”, è una categoria per definire la quale preferisco muovere dalla diversa titolazione “ l’avvocato nel rito” che – anche per il fatto di preludere a un argomentare su valori assoluti (“la verità”) – mi pare particolarmente confacente al caso.
Per entrare nel tema in forma “visiva” – come piace a me che pretendo di essere un pittore figurativo – immaginiamo un’aula diversa dallo squallore in cui si celebrano i nostrani processi; una anche più dignitosa di un’aula inglese: un tempio.
C’è un sacerdote (il giudice) che regola il rito assicurando che, svolgendo ogni officiante le proprie funzioni in modo appropriato, esso venga attuato come prescrive il cerimoniale.
Ci sono i cerimonieri, o concelebranti, ciascuno dei quali ha da assolvere a compiti ben precisi individuati ed elaborati in conformità alle funzioni esclusive e specifiche che gli sono attribuite.
Il tutto è preordinato a un risultato immediato, che è quello cui tutti particellarmente collaborano: che il rito sia impeccabile; a pena di doverlo ripetere.
C’è però un fine superiore mediato: quello di entrare in comunicazione con la divinità, con il mondo superiore o, fuor di metafora, col mondo dei valori. Fine tanto più conseguibile quanto più il rito sia perfetto.
Fatto questo “cappello” mi consento di proseguire; per un certo tratto, nella maniera che più mi è congeniale. Ossia sottoponendomi ad esame da parte di me stesso nella speranza di condurmi a una testimonianza attendibile.
D. Come si realizza un rito perfetto?
R. Lo si realizza se ciascuno opera osservandone le regole.
D. Le regole vanno osservate da ciascuno mirando alla realizzazione di un proprio fine personale?
R. No. Il fine è unico per tutti e consiste proprio nella corretta celebrazione del rito.
D. Ma allora la celebrazione è un valore a se stesso?
R. No, perché la correttezza della celebrazione è finalizzata al conseguimento di un valore superiore.
D. Questo vuol dire che c’è una scala di valori?
R. Sì, c’è un valore assoluto – la Giustizia – cui ci si può avvicinare realizzando un valore relativo: la correttezza nell’osservare le regole, che consente che il rito sia giusto; ossia di realizzare il processo giusto; e quanto più sia osservante delle regole e dei principi che le informano : quelle del giusto processo.
D. Se il fine è unico per tutti, cosa distingue i concelebranti?
R. La diversità delle funzioni.
D. Spiegati con altre parole.
R. Il rito prevede per ognuno dei partecipanti un ruolo e un percorso diversi. Se ciascuno li svolge correttamente le particelle rappresentate dalla concomitante attività dei singoli concorrono a produrre il rito giusto, il processo giusto.
D. Venendo all’avvocato, quale è la sua funzione in quanto difensore dell’imputato?
R. Assicurare che costui subisca un processo giusto.
D. Un processo giusto o un giusto processo?
R. Il “giusto processo” deve essere assicurato dal legislatore. L’avvocato, promuovendo le condizioni per la celebrazione del processo giusto, può essere di impulso al legislatore.
D. Ma mi sembra che dire “ assicurare che subisca un processo giusto” è come riportarci, senza aver dato risposte, al quesito di partenza?
R. No, perché “assicurare che subisca un processo giusto” implica una risposta nel senso di indicare due condotte processuali che l’avvocato deve tenere.
D. Quali?
R. La prima consiste nel controllo della correttezza delle particelle del processo che sono celebrate dagli altri protagonisti del processo.
D. E la seconda?
R. La seconda consiste nella protezione della presunzione di innocenza accordata dalla legge a ogni imputato perfino se si dichiari colpevole.
D. Dunque il ruolo dell’avvocato difensore sarebbe quello di assolvere a funzioni meramente “passive”.
R. No. C’è un equivoco. Quello di cui ho parlato sono condotte “ideali” cui l’avvocato deve allineare la propria attività, non integrano le attività “materiali” finalizzate alla realizzazione delle condotte.
D. In conclusione qual è la funzione dell’avvocato?
R. La funzione dell’avvocato consiste nel prestare all’accusato la assistenza tecnica che a costui necessita in conseguenza della conoscenza che gli manca delle regole del rito, nell’osservanza di alcuni presupposti che costituiscono, per noi, dei principi di civiltà: che l’accusato è assistito dalla presunzione di innocenza, che conseguentemente è la pubblica accusa a dover provare la colpevolezza dell’imputato, che l’imputato ha diritto di essere ammesso a contrastare le prove dell’accusa, che il diritto dell’imputato a difendere se stesso giunge fino a legittimare che lo stesso – personalmente – menta per scagionarsi.
D. Grazie. Ho terminato.
Quali considerazioni possono trarsi da questo autoesame?
In primo luogo mi pare di aver intravisto un principio importante: ossia che l’attività dell’avvocato non va posta in relazione con “la verità”. Verità che, parlando cinicamente e però in termini rigorosamente legali, è accidentale al processo. Infatti un processo può assolutamente essere “giusto” in termini processuali se assolve un reo e può essere assolutamente “giusto” anche se condanna un innocente. Talvolta ciò può essere determinato dalla imperfezione delle regole quand’anche applicate con rigore, talaltra può esserlo dalle coincidenze e dal “caso”. Fatto sta che può essere ingiusto assolvendo il reo o iniquo condannando l’innocente un processo giusto, il che significa che la verità non è una “categoria” bensì un semplice “accidente” di riferimento che tra l’altro solo talora ma non sempre è oggetto di considerazione nella celebrazione del rito. (Se così non fosse non avrebbero logica collocazione tutti quei processi che si concludono per vizi procedurali o anche per finzioni riconducibili al diritto sostanziale. Ad esempio col patteggiamento della pena).
Secondariamente dalla precedente conclusione si evince un ulteriore elemento: se non è l’attività dell’avvocato che va posta in diretta relazione con la verità, bensì deve esserlo il ruolo del difensore nel processo, è questa la relazione che va assoggettata ad analisi.
Il che forse facilita il compito di inquadrare il problema e consente qualche spunto di risposta attendibile.
Prima, però di scendere in argomento porrei tre premesse fondamentali: due di metodo e una di diritto.
La prima di metodo riguarda il fatto che qui io argomento soltanto attorno a un avvocato che abbia appreso “la verità” dei fatti dall’imputato direttamente o indirettamente da terzi (o attraverso risultanze oggettive) a seguito di una indagine difensiva.
La seconda di metodo è che qui prendo in considerazione solo la situazione dell’avvocato che ha effettivamente appreso la verità sui fatti, non di quello che si è convinto di una determinata verità probabile.
Quella di diritto sta nella affermazione che il rito tollera un contenutissimo margine di “ bugia” nel processo: cioè tuttora presso di noi consente soltanto all’Imputato di mentire pur di difendersi.
Tutto quel che viene consentito a taluni altri è di tacere. Può tacere chi è assistito dal segreto professionale, possono tacere alcune categorie di potenziali testimoni legati all’accusato da vincoli di parentela. Ma se questi e quelli scelgono di parlare sono vincolati al dovere di veridicità.
Tra “quelli” c’è l’avvocato: non può essere obbligato a testimoniare, è vincolato a tacere su quanto abbia appreso di pregiudizievole per il suo cliente nell’espletamento del mandato ricevuto, ma non può andare oltre. E quel “ non può essere obbligato” e “ è vincolato” costituiscono l’alfa e l’omega entro i quali corre la sua attività nello svolgimento del suo ruolo nel processo. Una attività e un ruolo che possono entrare in contatto in forme diverse col problema verità. (Un problema che – tra l’altro – non si propone sempre allo stesso modo, onde è anche la prospettiva nella quale esso appare che impone risposte differenziate. Poniamo ad esempio il caso di quel che può accadere in una difesa passiva: l’accusa non è in grado di addurre prove coerenti; il solo teste oculare è deceduto, altri testi a carico si confondono e contraddicono già nell’esame diretto…. È evidente che il problema sottostante al fatto che l’avvocato conosca la verità neppure sorge).
Perché ho detto in forme diverse?
Come tutti sappiamo ci sono due orientamenti di pensiero quanto al rapporto che si instaura tra il difensore e l’accusato di un crimine. C’è chi sostiene con argomentate ragioni che l’avvocato deve estrarre la verità dal cliente come un dentista cava un dente dalla bocca del paziente, gestendola poi secondo quanto stimerà opportuno nell’assolvimento del mandato. C’è anche, però, chi afferma che deve essere rispettata la libera scelta dell’imputato di confessare al proprio avvocato o di raccontargli invece quella che è la propria versione e sarà la tesi difensiva sui fatti.
Il soffermarsi su questi due orientamenti porta lontano dall’argomento di cui mi occupo e mette in discussione la tassatività di una delle affermazioni di taluno: che l’avvocato sia libero “di non assumere la difesa in casi che non ci sentiamo di affrontare o che non ci sentiamo di difendere”.
E’ una libertà che io condivido e difendo, – e peraltro è contestata in assoluto da certa scuola – ma di cui io stesso dubito una volta che nel colloquio preliminare l’avvocato abbia precisato al potenziale cliente di pretendere di conoscere la verità e costui gliela abbia detta. Un dubbio che ne implica a caduta un altro, come subito, evidenzierò.
Ipotizziamo: un imputato entra nel mio studio, mi dice di essere accusato di omicidio, che tutte le prove sono contro di lui anche se nel giorno e ora del fatto egli si trovava a cento chilometri di distanza. Fortunatamente c’è un certo Logo Visto che può confermare il suo alibi.
Cosa mi resta da fare se non indicare il soggetto quale testimone discarico ed esaminarlo sull’alibi?
Ora ipotizziamo una situazione alquanto diversa: un imputato entra nel mio studio, mi dice di essere accusato di omicidio , che tutte le prove sono contro di lui anche se è innocente, che fortunatamente c’è Logo Visto che può confermare il suo alibi, lo, invece di contentarmi, pesto il pugno sul tavolo: non voglio essere preso in giro, se devo accettare un caso voglio conoscere la verità, ecc. L’imputato obtorto collo cede: aveva mentito, l’accusa è vera, però c’è ugualmente un Logo Visto disponibile a fornire un falso alibi. Cosa faccio? Gli dico che lo difenderò solo se rinuncerà al falso alibi, altrimenti non lo accetterò come cliente.
Il soggetto non è soddisfatto, se ne va e si rivolge a un altro legale. Gli racconta la propria storia. L’avvocato lo torchia, come ho fatto io, ma questa volta il tipo tiene duro (anche perché corre il rischio che il suo diventi il segreto di Pulcinella). Il nuovo avvocato accetta il caso e indica Logo Visto come teste e lo esamina sull’alibi.
Ecco la situazione oggettiva: Logo Visto è un teste falso, ma il fatto che sia entrato nel processo non dipende necessariamente dalla volontà dell’avvocato. Vi può entrare con la sua consapevolezza se, sapendolo menzognero, l’avvocato lo indichi comunque violando propri precisi doveri; vi entra comunque se un accusato decida che intende farvelo entrare.
(Per completezza dovrei aggiungere una terza ipotesi, sulla quale tuttavia non mi soffermo: l’imputato entra nel mio studio, mi dice di essere accusato di omicidio, che tutte le prove sono contro di lui anche se è innocente, che fortunatamente c’è Logo Visto che può confermare il suo alibi, lo, invece di contentarmi, pesto il pugno sul tavolo: non voglio essere preso in giro, se devo accettare un caso voglio conoscere la verità, ecc. L’imputato obtorto collo cede: lui è effettivamente innocente e, non potendolo provare altrimenti, Logo Visto è disponibile a fornirgli un falso alibi).
Il caso è emblematico e sintetico dato che cerca di riportare a una sola ipotesi le molte situazioni che possono scaturire dal rapporto col cliente e dall’espletamento dell’indagine difensiva e i conseguenti interrogativi : “cosa succede a seguito di quanto apprendo?” e “fino a qual punto devo spingere il mio apprendere?”
Ha ragione, a mio avviso, chi afferma che il nuovo processo ci costringe a un modo tutto nuovo di pensare ai doveri professionali e deontologici dell’avvocato difensore. Ma questo, in verità, non perché il problema non si ponesse prima, bensì perché il processo inquisitorio (che riduceva sostanzialmente la funzione dell’avvocato alla perorazione conclusiva del procedimento impedendoci addirittura di andare a metter mano nelle prove) poteva consentirci di far finta di non vederlo o di equivocarlo e anche perché questa finzione era universalmente accettata dal sistema.
Tuttavia non era proprio così neppure prima e, quanto a ora, non possiamo più fingere. Anzi, ora non dobbiamo più fingere se vogliamo difendere e salvare la funzione sociale della professione.
Grazie a Dio possiamo parlare di questo aspetto essendo lontani dalle ideologie della cosiddette democrazie popolari che avevano ritagliato agli avvocati quella divisa di collaboranti di giustizia che taluno aspirava a importare anche qui.
La nostra situazione è del tutto diversa: le nostre democrazie occidentali ci coprono di prerogative civilissime, amplissime, – quella di poter tacere pur sapendo; quella di poter non rivelare prove a carico pur conoscendole – che comportano per la società un rischio elevatissimo: quello di non riuscire a perseguire il crimine.
Dobbiamo goderne con equilibrio proprio per preservarle visto che rappresentano anche un atto di fiducia della società nei nostri confronti. Esse ci saranno riconosciute finché ce ne mostreremo degni che, nel momento in cui non lo fossimo più, esse potrebbero subire delle restrizioni che provocherebbero un enorme passo indietro verso l’inciviltà del diritto.
L’esserne degni significa secondo me una sola cosa: essere rigorosi nel rispetto delle regole del processo e della nostra funzione nello stesso che è quella di perseguire la celebrazione di in processo giusto per l’imputato. Una funzione che, come credo emerga dalle leggi e dai principi sottostanti, ha spazi per il silenzio, non per la menzogna o per la connivenza con la stessa.
Se questo è esatto dobbiamo reimpostare tutti i rapporti avvocato-cliente abbandonando vecchi canoni o antiche finzioni che siano incompatibili con le premesse. Non solo, ma il pubblico, attraverso il rapporto del singolo avvocato col singolo cliente, va educato quanto a quella che è la funzione del difensore; deve sapere quali sono le sue prerogative e quelle del suo avvocato; deve sentire con certezza che l’avvocato non travalicherà da quelle prerogative; deve essere consapevole che la sua insincerità comporterà dei rischi esclusivamente per lui stesso, potendo falsare le scelte difensive del suo difensore, e anche per chi voglia agevolarlo; deve sapere che – conosciuta la verità – il suo difensore cercherà di assicurargli un processo giusto secondo le vie consentite dal rito ma non si presterà ad alterare la verità stessa.
Si tratta di una moralizzazione del rapporto che significherà – fino a quando non sarà generalizzata – un sacrificio in termini di clientela per chi già questo sacrificio non stia subendo (e di colleghi che lo subiscono ce ne sono); ma lo vedo come un modo fondamentale, anche di fronte all’incombenza del numero degli avvocati, per salvare la credibilità sociale e l’onorabilità individuale della professione del penalista lasciando a chi vorrà la libertà di emarginarsi segnalandosi per contrasto.
Avv. Domenico Carponi Schittar